Approfondimenti
Turismo: reti di imprese che riescano a fare sistema per restare competitivi
Intervista in esclusiva a Luca Zamparini, professore associato di Unisalento esperto di Economia dei Servizi in particolare trasporti e turismo e di Unione Europea: «Sistema Salento o improvvisazione? Situazione intermedia. Ci sono le potenzialità per fare sistema ma tali potenzialità devono essere colte e sviluppate in un’ottica di medio-lungo periodo…»

Ospite dell’edizione 2021 della Notte dei Sensi a Tricase Porto, Luca Zamparini è professore associato di Economia politica e responsabile dei corsi di Economia Politica presso il corso di laurea in Giurisprudenza e di Economia del Turismo presso il corso di laurea in Manager del Turismo, nonché membro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
 I suoi principali interessi di ricerca sono l’Economia dei Servizi (in particolare trasporti e turismo) e l’Unione Europea.
I suoi principali interessi di ricerca sono l’Economia dei Servizi (in particolare trasporti e turismo) e l’Unione Europea.
È stato editor di vari volumi e special issues ed è autore di svariati articoli e capitoli di libro sui suoi temi di ricerca. Ha partecipato a molteplici convegni nazionali ed internazionali come speaker, responsabile di sessione e discussant. È anche responsabile del Cluster 5 su Leisure, Recreation and Tourism del NECTAR (Rete attiva della Comunicazione europea e attività di ricerca sui trasporti), una rete di ricerca scientifica creata nel 1992 che annovera più di 200 membri in Europa e si occupa di temi legati ai trasporti ed alle comunicazioni.
Ha partecipato al team di coordinamento del progetto europeo EU-STELLA sul Trasporto sostenibile in Europa e collegamenti e relazioni con l’America.
LA SFIDA DA VINCERE PER IL PROSSIMO DECENNIO
 Il Salento è oggi tra le mete preferite dai turisti, non solo italiani. Secondo lei tutto il comparto e l’indotto hanno la struttura per reggere tale peso? Oppure rischiamo di giocarci la credibilità e diventare un fenomeno provvisorio? Lei sostiene che i fenomeni turistici sono destinati ad essere ciclici. Cosa ci resterà quando questo ciclo sarà terminato? Come dovremmo attrezzarci come Salento per non rimanere con un pugno di mosche in mano?
Il Salento è oggi tra le mete preferite dai turisti, non solo italiani. Secondo lei tutto il comparto e l’indotto hanno la struttura per reggere tale peso? Oppure rischiamo di giocarci la credibilità e diventare un fenomeno provvisorio? Lei sostiene che i fenomeni turistici sono destinati ad essere ciclici. Cosa ci resterà quando questo ciclo sarà terminato? Come dovremmo attrezzarci come Salento per non rimanere con un pugno di mosche in mano?
«La teoria economica che si occupa di turismo ha ormai da tempo evidenziato che tutte le destinazioni sono caratterizzate da un ciclo di vita che inizia con l’esplorazione e l’avviamento, prosegue con lo sviluppo e la maturità e termina quindi con la stagnazione e la decadenza. Tenendo presente il Salento, risulta importante fare due considerazioni. La prima riguarda il fatto che tale destinazione è sicuramente arrivata alla sua fase della maturità.
Tralasciando gli ultimi due anni, influenzati dal Covid-19 e dalla relativa difficoltà di compiere vacanze all’estero, il Salento dovrebbe attrezzarsi per evitare di vivere le ultime due fasi, che non sono un destino ineluttabile. Le destinazioni possono evitare di arrivare in tali situazioni compiendo quello che la teoria chiama rejuvenation (ringiovanimento) o restyling, che può essere organizzativo quando si introduce un prodotto nuovo o reale quando si cerca di offrire il medesimo tipo di turismo, migliorandone la qualità. Il Salento ha tutte le potenzialità sia per offrire prodotti nuovi (si pensi ad esempio al turismo culturale o enogastronomico) sia per migliorare la qualità dell’offerta turistica. A mio modo di vedere, questo rappresenterà la sfida principale del prossimo decennio».
Tra i concetti sui quali lei insiste, la necessità di fare sistema tra gli attori in campo per aumentare la competitività ed avere un ritorno che giovi a tutti. Particolarmente interessante il concetto di relazione e collaborazione diagonale e orizzontale…
«Le reti di imprese che riescano a fare sistema tra di loro rappresentano sicuramente un punto chiave per lo sviluppo di una migliore e più competitiva offerta turistica. Ciò deriva dal fatto che l’esperienza turistica è costituita, da un punto di vista economico, dal consumo di una serie di beni e servizi complementari tra di loro, che concorrono a soddisfare le esigenze dei turisti ed a motivarli a tornare in una determinata destinazione. Già nel 2009, lo Stato italiano ha promulgato una legge (5/2009) per agevolare la creazione di reti imprese con lo scopo di migliorarne la competitività ed il potenziale innovativo. A tutt’oggi, questa opportunità sembra essere stata sfruttata poco nell’ambito del turismo. Al di là di legge nazionali o locali, lo sviluppo di reti di impresa dipende dalla capacità dei singoli imprenditori di capire il potenziale economico e di mercato che tali iniziative possono sviluppare. Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, mi sembra che la tipologia di reti che ha maggiore possibilità di sviluppo nel comparto turistico è quella diagonale; ossia quella in cui si mettono insieme imprese che offrono beni e servizi complementari tra di loro. Minore appeal sembra avere nel turismo la forma classica delle reti orizzontali, costituite da una serie di imprese che offrono tutte il medesimo bene o servizio, data la percezione che molti imprenditori hanno rispetto ai rischi di perdita di controllo del mercato e di possibilità che le altre imprese della rete si approprino delle peculiarità competitive di cui ogni singola impresa dispone. Inoltre, va tenuto presente che bisogna sapere creare un sistema chiaro ed allettante di incentivi (economici e non solo) che motivino i singoli imprenditori a fare sistema tra di loro ed a costituire delle reti formali o informali. In mancanza di tali incentivi, difficilmente le reti nascono e facilmente falliscono».
Dal suo punto di vista esiste oggi un “Sistema Salento” o è tutto lasciato all’improvvisazione e alla casualità?
«La risposta a questa domanda non può che essere un’opinione personale. Ritengo che ci siano degli spunti positivi (ad esempio la creazione del brand “Salento d’amare” o la fornitura di un servizio quale Salento in Bus che tenta di raccordare efficacemente Lecce con le varie marine salentine nel periodo estivo). La mancanza di una prospettiva globale ad un qualcosa che si avvicini ad un sistema Salento si può però riscontrare qualora si consideri la scarsa efficacia, a tutt’oggi, di destagionalizzare la domanda turistica. Tema fondamentale per il Salento anche per l’impatto che avrebbe in termini di occupazione stabile. Riuscire ad ottenere una sensibile destagionalizzazione richiederebbe uno sforzo congiunto ed una collaborazione efficiente tra settore pubblico ed operatori privati. D’altra parte, dire che tutto è lasciato all’improvvisazione ed alla casualità mi sembra un po’ eccessivo. Diciamo che ci si trova in una situazione intermedia. Ci sono tutte le potenzialità per potere fare sistema ma tali potenzialità devono essere colte e sviluppate in un’ottica di medio-lungo periodo e grazie alla creazione di rapporti di fiducia e di collaborazione stabile tra operatori del turismo».
TRASPORTI: «NON CONFIDIAMO TROPPO NEL PNRR»
 Tema di grande attualità il PNRR (Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Nel settore dei trasporti, soprattutto un incentivo all’estensione dell’Alta Velocità su tutto il territorio. A quanto è dato sapere, però il Salento rischia di essere di nuovo escluso perché nella programmazione del Piano l’Av si fermerebbe a Bari…
Tema di grande attualità il PNRR (Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Nel settore dei trasporti, soprattutto un incentivo all’estensione dell’Alta Velocità su tutto il territorio. A quanto è dato sapere, però il Salento rischia di essere di nuovo escluso perché nella programmazione del Piano l’Av si fermerebbe a Bari…
«Questa domanda mi stimola a fare due considerazioni. La prima è che la resilienza è un concetto ormai abusato sia dagli studiosi sia dagli operatori politici ed amministrativi. Essa implica la capacità di un corpo (nel nostro caso di un sistema economico, sia esso l’Italia o il Salento) di subire uno shock, di assorbirlo e di ritornare alla sua configurazione originaria.
Sono fermamente convinto che l’Italia in generale ed il Salento in particolare non abbiano bisogno di ritornare alla situazione caratteristica del periodo pre-Covid ma di evolvere e migliorare. Fatta questa premessa, l’analisi dei fondi messi a disposizione dal PNRR per la mobilità non fanno presumere che aree periferiche quali il Salento verranno ad esserne molto avvantaggiate. La grande maggioranza dei fondi verrà destinata al potenziamento dell’Alta Velocità che difficilmente, come giustamente citato nella domanda, arriverà fino al Salento. D’altra parte, io ritengo che il Salento, e molte altre aree di Italia, abbiano la necessità di cercare di pianificare le loro traiettorie di sviluppo contando soprattutto sulle potenzialità, professionalità e forze interne piuttosto che attendere gli aiuti esterni. Solo in questo modo si possono porre le basi di un forte e duraturo sviluppo locale».
In tanti invocano una metropolitana di superficie al posto della vetusta linea della Sud Est che colleghi in maniera “pulita” e funzionale tutti gli angoli del Salento. Secondo lei è fattibile?
«La metropolitana di superficie rappresenta sicuramente un passaggio importante per una migliore offerta di trasporto pubblico locale in Salento ma è anche solo un primo passo. Nel settore dei trasporti, più che nel turismo ed in qualsiasi altro settore, è essenziale che si sviluppi un sistema coeso, flessibile e soprattutto multimodale. Vanno raccordate varie modalità di trasporto (soprattutto ferroviario e su strada) in modo da potere realmente creare un sistema infrastrutturale ed un’offerta integrata che permettano a residenti e turisti di muoversi agilmente sul territorio. Penso, ad esempio, alla necessità di arrivare ad un’integrazione tariffaria ed alla necessità di raccordare gli orari delle varie offerte di servizi di trasporto per minimizzare il tempo degli spostamenti e soprattutto quelle fasi (l’attesa) che maggiormente incidono sulla percezione di utilità e di efficienza del servizio da parte degli utenti. Ciò può essere raggiunto solo coordinando le varie imprese di trasporto (altro esempio di una rete efficace) in modo da fornire un’offerta integrata, efficace e ad un costo ragionevole per gli utenti».
Giuseppe Cerfeda
Approfondimenti
Santu Pati, il Capodanno contadino del Salento
Il 17, 18 e 19 gennaio a Tiggiano la Festa di Sant’ippazio, patrono del piccolo borgo medievale e protettore della virilità e della fertilità maschile simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, prezioso simbolo del paese e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale. Tre serate di musica, tradizione e gastronomia tipica con il Capodanno contadino del Salento. Grande festa di chiusura lunedì 19 , giorno del santo, con la fiera mercato tradizionale, il caratteristico rito dell’innalzamento dello stendardo di 6 metri portato in processione con il santo e I Calanti in concerto

È il vero Capodanno contadino del Salento, la festa di “Santu Pati” a Tiggiano.
Si celebrerà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un programma intriso di tradizioni antiche, di saggezza arcaica e di quelle consuetudini contadine che, tra fede e goliardia, rendevano meno duro il lavoro nei campi.
Sant’Ippazio è protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio locale, diventata prezioso simbolo di Tiggiano e inserita dal 2004 nell’elenco nazionale PAT-prodotto agroalimentare tradizionale.
Il Comune salentino è l’unico d’Italia a celebrare Sant’Ippazio e anche quest’anno lo fa dedicandogli un intenso programma di riti religiosi e civili, una festa di devozione con grandi appuntamenti di intrattenimento per tutti.
Organizzata dal Comitato Festa Patronale della Parrocchia di Tiggiano con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Tiggiano, in collaborazione con PugliArmonica, si svolge nel centro del paese, tra la Chiesa Madre Sant’Ippazio, Piazza Olivieri, Via Sant’Ippazio e Piazza Mario De Francesco.
Sabato 17 gennaio, alle 19, apertura dei festeggiamenti con accensione dei bracieri monumentali, al suono della Banda di Matino “V. Papadia”, e poi al via la prima delle tre serate di Capodanno contadino, a cura del Comitato Feste, con prodotti tipici e piatti tradizionali, come la paparotta, la “merenda contadina” di una volta, una minestra povera ma molto sostanziosa fatta di rape, piselli, pezzi di pane soffritto.
Alle ore 21 arriva anche l’intrattenimento in musica, in piazza Mario De Francesco, con Alta Frequenza Live Show.
Si entrerà nel vivo domenica 18.
Seconda serata per il Capodanno contadino e, dalle 21, la musica diventa colonna sonora di questa grande celebrazione del santo patrono, con Shocchezze in concerto.
Grande festa di chiusura lunedì 19 gennaio, giorno del santo, con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi tra cui, dalle ore 6 alle 13, la Fiera Mercato tradizionale, arricchita tra l’altro dalla musica del Concerto Bandistico Municipale Città di Taviano alle ore 9.
Alle ore 15 uno dei momenti più simbolici e caratteristici di questa festa, il pittoresco innalzamento dello stendardo di 6 metri, legato a un drappo rosso, portato in processione con la statua del santo. L’appuntamento con le diverse squadre di portatori è sul sagrato della chiesa, per contendersi l’onore di portare la statua e lo stendardo.
Una vera e propria contrattazione, che si conclude con un pittoresco rullo di tamburi e l’uscita dello stendardo, mantenuto in posizione parallela al suolo per tutto il tragitto, dalla chiesa del santo patrono fino alla chiesetta dell’Assunta, dove poi sarà issato con un solo e deciso gesto dal portatore, che assicura così al paese ai cittadini un’annata prospera e un raccolto generoso.
Una vera e propria prova fisica, salutata dalle campane e dagli applausi dei presenti, assiepati ai lati delle strade, che culmina nella processione accompagnata dalla banda e dai fuochi d’artificio.
Alle ore 18 di lunedì 19 gennaio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Poi, dalle 19, la continuazione del Capodanno contadino e, alle 20,30, il concerto de I Calanti, storica formazione di musicisti e ballerini che rinnovano una tradizione musicale di famiglia raccontando in musica la cultura e le tradizioni popolari del Salento.
Finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.
LA PESTANACA DELLA VIRILITÀ
Tiggiano è incastonato in un paradiso naturale, tra distese di grano e terra rossa, antiche pagghiare e masserie cinquecentesche, che ha incantato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren che, con suo marito, il regista Taylor Hackford, qui ha messo su casa, un buen retiro italiano, dove vivono circa sei mesi l’anno.
In questo piccolo comune (diventato un caso per l’aumento di popolazione, in controtendenza rispetto agli altri paesini del Sud) a dettare il tempo è ancora il ritmo del calendario agricolo, della vita contadina di una volta.
Non a caso anche la devozione per il patrono qui passa per un ortaggio, la pestanaca.
Cara al santo, la gustosa carota, sempre presente a pranzo e a cena, insieme a finocchi, carote, sedano, per un colorato miscuglio di subbrataula, è l’ortaggio simbolo del patrono della virilità e della fertilità maschile, taumaturgo, invocato contro l’ernia inguinale degli uomini.
La tradizione vuole che, ambasciatrici e intermediarie per vocazione, siano le donne a farsi da tramite perché il santo interceda e guarisca i mali degli uomini: con discrezione, strofinano la statua di Sant’Ippazio con un fazzoletto, lo stesso che passeranno poi sulla parte da guarire dell’uomo di casa interessato.
Per le mamme, invece, è consuetudine raccogliersi in preghiera insieme al piccolo maschietto di casa, nella chiesa di Sant’Ippazio, per evocarne la benedizione.
Fede, tradizione culinaria e rituali quasi pagani, si mescolano nei giorni della ricorrenza.
La cerimonia del santo patrono è anche un’importante vetrina commerciale, anche questa una consuetudine ereditata dalle “fere” di una volta, le fiere mercantili, appuntamenti importanti per i produttori locali.
Durante i giorni di festa, infatti, ci si ritrova davanti banchetti con “pestanache” in originali composizioni, nelle caratteristiche ceste di vimini. Un campionario di colori e genuinità, che punta alla salvaguardia della biodiversità alimentare, con la partecipazione degli agricoltori locali, fieri di fare sfoggio delle proprie produzioni.
Un ortaggio locale, quindi, per un santo mediorientale.
Il culto di Sant’Ippazio, d’origine turca, è infatti giunto insieme ai monaci basiliani nel Salento, dove è per tutti semplicemente “Santu Pati”, quasi un amico, un vicino di casa, ma soprattutto un confidente, un orecchio discreto al quale confessare le preoccupazioni più intime, i timori più nascosti, certi di trovare sempre ascolto e comprensione.
IL PROGRAMMA RELIGIOSO
10 – 18 GENNAIO – NOVENA
Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica e Novena in Chiesa Madre
DOMENICA 18 GENNAIO – VIGILIA
Ore 18:00 – Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica vigiliare e Novena
Ore 19:00 – Chiesa Madre Concerto dell'”Artistica Inclusione” della scuola di musica “W.A. Mozart” – direttore M. Antonio Mastria
LUNEDÌ 19 GENNAIO – SOLENNITÀ DI SANT’IPPAZIO
Ore 8:00 – 9:30 – 11:00 Celebrazioni Eucaristiche in Chiesa Madre
Ore 16:00 Inizio della processione secondo il seguente itinerario: Chiesa madre – via S. Ippazio – via V. Veneto – via XXIV Maggio – via del Mare – via Diaz – via Mazzini – Via M. di via Fani – via Volta – via Filzi – via Oberdan – via Battisti – via Solferino – via Petrarca – via V. Veneto – via Roma – p.zza Roma – via Cortina – p.zza M. De Francesco – via S. Ippazio – Chiesa Madre.
Al termine della processione, sul sagrato della Chiesa Madre, per la prima volta il Sindaco consegnerà le chiavi del paese al Santo Patrono
Ore 18:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca
IL PROGRAMMA CIVILE
SABATO 17 GENNAIO
Ore 19:00 – Via Sant’Ippazio
Apertura del capodanno contadino con l’accensione dei bracieri monumentali.
Stand gastronomici con prodotti tipici.
BANDA DI MATINO “V. PAPADIA” IN CONCERTO
Ore 21:00 – Piazza Mario De Francesco
ALTA FREQUENZA LIVE SHOW
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 21:30 – Piazza Carmine Olivieri
SHOCCHEZZE IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
LUNEDÌ 19 GENNAIO – FESTA PATRONALE
Ore 6:00 – 13:00 – Vie centrali
Tradizionale Fiera mercato di Sant’Ippazio
Ore 9:00 – Vie centrali BANDA DI TAVIANO – GIRO MUSICALE
Ore 15:00 – Sagrato Chiesa Madre Tradizionale
Asta del Santo e dello stendardo
A seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla BANDA DI TAVIANO
Ore 17:00 – Sagrato Chiesa Madre
Al rientro della processione lancio dei palloni aerostatici a cura della ditta Pulli di Veglie
Ore 20:30 – Piazza Mario De Francesco I CALANTI IN CONCERTO
Stand gastronomici con prodotti tipici
Ore 22:30 – Viale stazione
Spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta Dario Cosma di Arnesano, donato dalla famiglia De Francesco Pietro
Luminarie a cura della ditta Arte e Luce di Scorrano.
Luna Park in Piazza Cuti.
📍 Segui il Gallo Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
Live News su WhatsApp 👉 clicca qui
- Il Santo in processione
- Il pittoresco innalzamento dello stendardo
- La pestanaca
Approfondimenti
Lupini, carrubi e fichi i migliori figli spuri della terra salentina
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano…

di Rocco Boccadamo
Sono frutti, prodotti, derrate, cui, adesso, si annette rilievo scarso, se non, addirittura nullo; si è quasi arrivati a ignorarne l’esistenza, la cura e l’uso.
Sulla scena delle risorse agricole locali, resistono appena, con alti e bassi, le granaglie, le olive, l’uva, gli agrumi, gli ortaggi e/o verdure.
 Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
Lupini, carrube e fichi sono, insomma, divenuti figli minori e spuri della terra, le relative coltivazioni appaiono rarefatte e, di conseguenza, i raccolti trascurati o abbandonati. Mentre, sino alla metà del ventesimo secolo ma anche a tutto il 1960/1970, rappresentavano beni indicativi per i bilanci delle famiglie di agricoltori e contadini ed elementi di non poco conto per le stesse, dirette occorrenze alimentari.
I primi, della sottofamiglia delle Faboidee, al presente richiamati solo sulla carta e nelle enciclopedie come utili ai fini della decantata “dieta mediterranea”, si trovavano diffusi su vasta scala, specialmente nelle piccole proprietà contadine attigue alla costiera, fatte più di roccia che di terra rossa, si seminavano automaticamente e immancabilmente senza bisogno di soverchia preparazione del terreno, né necessità di cure durante il germoglio e la crescita delle piante, dapprima in unità filiformi, poi robuste e ben radicate sino all’altezza di metri 1 – 1,50, recanti, alla sommità, rudi baccelli contenenti frutti a forma discoidale, compatti, di colore fra il giallo e il beige – biancastro.
Al momento giusto, le piante erano divelte a forza di braccia e sotto la stretta di mani callose e affastellate in grosse fascine o sarcine. A spalla, i produttori trasportavano quindi tale raccolto nel giardino o campicello, con o senza aia agricola annessa, più prossimo alla casa di abitazione nel paese, lasciandolo lì, sparso, a essiccare completamente sotto il sole.
Dopo di che, avevano luogo le operazioni di separazione dei frutti dai baccelli e dalle piante, sotto forma di sonore battiture per mezzo di aste e forconi di legno. Diviso opportunamente il tutto, con i già accennati discoidi, si riempivano sacchi e sacchetti.
Il prodotto, in piccola parte, era conservato per le occorrenze, diciamo così, domestiche: previa bollitura e aggiuntivo ammorbidimento e addolcimento con i sacchetti tenuti immersi nell’acqua di mare, i lupini diventavano una sorta di companatico o fonte di nutrimento di riserva e, in più, servivano ad accompagnare i “complimenti”, consistenti in panini, olive, sarde salate, peperoni e vino, riservati, in occasione dei ricevimenti nuziali, agli invitati maschi. Invece, l’eccedenza, ossia la maggior parte del raccolto, era venduta a commercianti terzi.
° ° °
 Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Le carrube sono i favolosi e bellissimi pendagli, color verde all’inizio e marrone sul far della maturazione, donatici dagli omonimi maestosi alberi, taluni di dimensioni monumentali, tutti affascinanti.
Anche riguardo alle carrube, non si pongono attenzioni particolari, salvo periodiche potature delle piante, i frutti si raccolgono, al momento, purtroppo, da parte di pochi, attraverso tocchi con aste di legno, un’operazione denominata abbacchiatura, come per le noci.
Il prodotto, copioso e abbondante ad annate alterne e riposto in sacchi di juta, oggi è indirizzato esclusivamente alla vendita a terzi; al contrario, in tempi passati ma non lontanissimi, le carrube, dopo l’essiccazione al sole, erano in parte abbrustolite nei forni pubblici del paese e, conservate in grossi pitali in terracotta, insieme con le friselle e i fichi secchi, componevano le colazioni e, in genere, i frugali pasti in campagna dei contadini.
Piccola nota particolare, d’inverno, poteva anche capitare di grattugiare le carrube e, mediante la graniglia così ottenuta mescolata con manciate di neve fresca (beninteso, nelle rare occasioni in cui ne cadeva), si realizzava un originale e gustoso dessert naturale e sano.
° ° °
I fichi, al momento, purtroppo, lasciati, in prevalenza, cadere impietosamente ai piedi degli alberi, erano, una volta, oggetto di una vera e propria campagna di raccolta, ripetuta a brevi intervalli in genere sempre nelle prime ore del mattino, con immediato successivo sezionamento (spaccatura) dei frutti e disposizione dei medesimi su grandi stuoie di canne, “cannizzi”, e paziente fase di essiccazione sotto il sole.
Allo stesso modo delle carrube, in parte erano poi cotti nei forni e andavano a integrare le fonti dell’alimentazione famigliare, in parte erano somministrati agli animali domestici, in parte, infine, erano venduti.
Soprattutto, se non proprio, per i fichi, le famiglie avevano l’abitudine, in luglio e agosto, di spostarsi fisicamente dalle case di abitazione nel paese, nelle piccole caseddre di pietre situate nelle campagne, cosicché si risparmiavano le ore occorrenti per l’andata e il ritorno di ogni giorno a piedi e avevano, in pari tempo, agio di attendere direttamente e più comodamente a tutte le fasi della descritta raccolta.
Non c’è che dire, ieri, in un modello esistenziale più semplice, alla buona e intriso di spontanea connaturata operosità, si aveva interesse, e attenzione, anche per beni “poveri” ma, con ciò, non meno utili di altri; oggi, il concetto di valore si è in certo senso ripiegato su se stesso e finalizzato a obiettivi e orizzonti di tutt’altra stregua, fra cui miraggi a portata di mano.
Approfondimenti
Illuminare balconi e terrazzi: idee d’effetto anche per chi non ha il giardino

L’illuminazione esterna durante il periodo delle festività rappresenta un gesto di condivisione della gioia e un modo per estendere il calore domestico oltre le mura dell’abitazione. Spesso si crede che la creazione di allestimenti luminosi d’impatto sia un privilegio riservato a chi possiede ampi giardini, ma balconi e terrazzi, anche se di piccole dimensioni, offrono opportunità creative straordinarie. Con un’attenta pianificazione e l’utilizzo di soluzioni adatte, è possibile trasformare questi spazi in veri e propri palcoscenici luminosi. L’impiego strategico delle lucine di Natale è fondamentale per infondere magia e visibilità anche negli angoli più ristretti.
La sicurezza e la scelta dei materiali
Prima di procedere con qualsiasi allestimento luminoso esterno, è imperativo considerare gli aspetti legati alla sicurezza e alla durabilità. L’uso di prodotti certificati e specificamente contrassegnati per l’uso in esterni (con grado di protezione IP adeguato, generalmente IP44 o superiore) è essenziale per resistere all’umidità, alla pioggia e alle variazioni termiche. È altresì prudente optare per soluzioni a basso consumo energetico, come le luci LED, che non solo garantiscono una lunga vita operativa ma riducono anche l’impatto sulla bolletta elettrica. La scelta di alimentatori e prolunghe anch’essi resistenti alle intemperie assicura che l’installazione sia stabile e priva di rischi.
L’arte di definire i contorni
L’illuminazione efficace di un balcone o di un terrazzo si basa sulla capacità di definire e valorizzare i contorni dello spazio disponibile. Invece di installare le luci in modo casuale, è opportuno concentrarle lungo le ringhiere, le cornici delle finestre o i bordi del pavimento. Le catene luminose disposte orizzontalmente lungo la ringhiera creano un effetto visivo ordinato e accogliente, che demarca elegantemente lo spazio. Per un effetto più sontuoso e stratificato, si possono utilizzare le stalattiti luminose o le tende di luci, facendole scendere verticalmente dalla parte superiore del balcone. Queste soluzioni offrono una densità luminosa immediata e trasformano la facciata dell’edificio in una vera e propria tela festiva.
Sfruttare la verticalità e gli elementi esistenti
Nei piccoli terrazzi, la verticalità è la chiave per massimizzare l’impatto senza sacrificare lo spazio calpestabile. È possibile decorare le pareti esterne, se consentito dal regolamento condominiale, con reti luminose che simulano un effetto di cielo stellato o con motivi sagomati a tema festivo. I vasi e le fioriere esistenti possono diventare parte integrante dell’allestimento: luci a batteria possono essere posizionate all’interno dei vasi o avvolte attorno alle piante sempreverdi. L’utilizzo di rami luminosi inseriti in fioriere decorative offre un’alternativa sofisticata all’albero tradizionale, creando punti luce alti e sottili che non occupano spazio in larghezza.
L’uso di elementi decorativi a pavimento
Anche se lo spazio è limitato, è possibile introdurre elementi luminosi a pavimento che aggiungano profondità e magia. Le lanterne da esterno, alimentate a batteria o con candele a LED, possono essere posizionate negli angoli o vicino alla porta d’ingresso. Queste lanterne offrono una luce calda e diffusa che evoca un senso di intimità e accoglienza. Un’altra idea d’effetto è l’utilizzo di proiettori laser o LED a tema festivo, che proiettano fiocchi di neve o figure natalizie direttamente sulla parete esterna dell’edificio. Questa soluzione crea un grande impatto visivo con un ingombro fisico minimo.
Colore e temperatura: la scelta del tono emotivo
La temperatura del colore delle luci natalizie ha un’influenza decisiva sul tono emotivo dell’allestimento. Le luci bianco caldo, che tendono al giallo, sono preferite per creare un’atmosfera tradizionale, accogliente e rassicurante, che ricorda il tepore dei focolari. Al contrario, le luci bianco freddo o quelle blu e viola creano un effetto più moderno, glaciale ed elegante. Per un risultato armonioso, è generalmente consigliato non mescolare troppe temperature di colore diverse nello stesso spazio. La coerenza cromatica è essenziale per evitare un effetto caotico e per rafforzare la sensazione di ordine e cura nell’allestimento.
Soluzioni pratiche per l’alimentazione
Nei balconi dove le prese elettriche esterne sono insufficienti o assenti, le soluzioni a batteria o a energia solare sono una risorsa preziosa. Le catene luminose a batteria, spesso dotate di timer incorporato, consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento, ottimizzando il consumo e liberando l’utente dall’onere di collegare o scollegare le luci ogni sera. I pannelli solari, sebbene meno performanti nelle brevi giornate invernali, sono ideali per i punti esposti al sole, offrendo una soluzione ecologica e totalmente autonoma dal punto di vista energetico. L’attenzione alla praticità operativa è fondamentale per assicurare che l’allestimento luminoso sia fonte di gioia e non di stress gestionale.
-

 Alessano4 settimane fa
Alessano4 settimane faMaserati contro Renault sulla statale: perde la vita professore di Alessano
-

 Alessano3 settimane fa
Alessano3 settimane faScontro mortale tra Alessano e Lucugnano, positivo all’alcoltest conducente della Maserati
-

 Cronaca4 settimane fa
Cronaca4 settimane faVigilante salentino morto per il freddo su cantiere Olimpiadi a Cortina
-

 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane faI NAS sequestrano oltre 9 quintali di alimenti
-
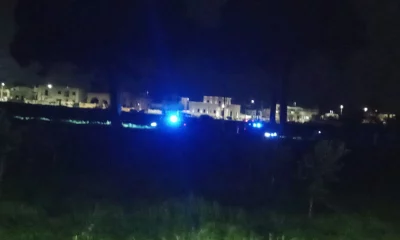
 Attualità2 giorni fa
Attualità2 giorni faTragedia a Miggiano: anziano trovato morto sotto la sua auto
-

 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane faCosa accadrà alla Piscina di Marina Serra?
-

 Attualità4 settimane fa
Attualità4 settimane faTricase: “I bus fermano sulla rotatoria, è progettata male”
-
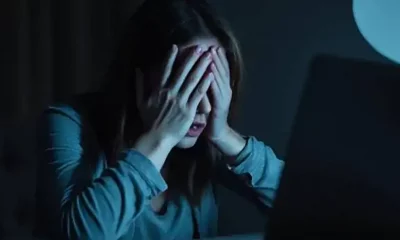
 Cronaca3 settimane fa
Cronaca3 settimane fa“Mia Moglie” su Facebook: il gestore era salentino








































